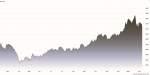Le parole pronunciate a bordo dell’Air Force One hanno avuto l’effetto di una scossa tellurica nelle capitali europee. Quando il presidente Donald Trump ha definito “inaccettabile” qualsiasi soluzione che non preveda un controllo statunitense sulla Groenlandia, il messaggio è apparso inequivocabile: non una proposta, ma una pretesa.
Il riferimento alla NATO, chiamata a “guidare il processo”, ha completato il quadro, trasformando un’ipotesi geopolitica in una prova di forza sull’architettura stessa dell’Alleanza Atlantica.
Al di là della terminologia diplomatica, ciò che è cambiato è il modello di prezzo della partnership transatlantica. Per decenni, la sicurezza fornita dagli Stati Uniti è stata una garanzia a costo fisso o, in altre parole, allineamento politico e basi militari in cambio di protezione. Oggi quel prezzo è cambiato, soggetto agli umori dell’esecutivo americano.
L’Articolo 5 della NATO, sempre più incerto e sempre meno automatico
La NATO è sempre stata concepita come uno strumento binario: si è dentro o si è fuori, protetti o esposti. L’Articolo 5 ne rappresenta il cuore. Ma i segnali arrivati dagli Stati Uniti, in particolare il rifiuto di escludere azioni unilaterali sulla Groenlandia, hanno introdotto un elemento di incertezza in quella che doveva essere una clausola automatica.
A Bruxelles, la pazienza strategica che ha caratterizzato le reazioni europee negli ultimi anni si è dissolta rapidamente. La cattura del presidente venezuelano Nicolás Maduro da parte delle forze statunitensi, avvenuta il 3 gennaio, ha contribuito a ricalibrare le percezioni dei politici europei. Non sorprende quindi la durezza delle parole della premier danese Mette Frederiksen, che ha avvertito come un’azione militare sulla Groenlandia segnerebbe la fine dell’Alleanza “così come la conosciamo”.
Il mito delle miniere chiavi in mano sotto il ghiaccio
La possibile intesa che si profila per la Groenlandia ruota attorno a due pilastri: più spesa per la sicurezza e accesso alle risorse. È soprattutto quest’ultimo elemento a essere presentato come la leva capace di allentare le tensioni. L’idea è semplice e cioè concedere agli Stati Uniti una quota della ricchezza mineraria groenlandese per soddisfare la fame occidentale di terre rare.
Ma la narrazione si scontra con la realtà industriale. Secondo lo U.S. Geological Survey, la Groenlandia ospita uno dei maggiori potenziali giacimenti mondiali di ossidi di terre rare, incluse quantità rilevanti di neodimio e disprosio, essenziali per i motori elettrici e per sistemi d’arma avanzati come l’F-35. Il problema è che, a oggi, sull’isola non esiste nemmeno una miniera di terre rare in attività.
Il limite non è solo normativo, ma fisico. L’80% dei 2,17 milioni di chilometri quadrati della Groenlandia è coperto da ghiacci. Non esistono strade che colleghino i centri abitati, ogni macchinario deve arrivare via mare o in elicottero. Analisi di settore stimano che sviluppare una miniera in ambiente artico comporti costi di capitale dal 150% al 300% superiori rispetto a regioni temperate come Australia o Brasile. A questo si aggiunge il problema energetico poiché non c’è rete elettrica a cui collegarsi.
Se l’Unione Europea decidesse di raddoppiare gli investimenti per rendere questi progetti appetibili agli occhi di Washington, si tratterebbe di una evidente sovvenzione geopolitica, con denaro pubblico per rendere sostenibile ciò che il mercato, da solo, non giustifica. In sostanza, costruire una miniera in perdita per comprare stabilità politica.
Accesso o proprietà: il paradosso strategico
Il secondo pilastro dell’offerta europea riguarda il rafforzamento della sicurezza nell’Artico. Il segretario generale della NATO Mark Rutte ha già parlato della necessità di “potenziare la sicurezza artica”, in linea con la richiesta americana di una maggiore condivisione degli oneri.
Eppure, osservando la situazione attuale, emerge un paradosso. Se l’obiettivo fosse esclusivamente strategico – contenere Russia e Cina – gli Stati Uniti dispongono già di tutto ciò che serve. La base spaziale di Pituffik, ex Thule, è un nodo cruciale della difesa missilistica nordamericana. L’accordo di difesa del 1951 garantisce a Washington ampi diritti operativi sull’isola, inclusa la capacità di monitorare il corridoio GIUK e proiettare potenza militare.
La richiesta di controllo formale della Groenlandia, più che di semplice accesso, suggerisce quindi una motivazione diversa: non tanto l’utilità militare, quanto la volontà di sancire una sfera d’influenza su una mappa.
Strappare il contratto del 1945
Il costo più alto, tuttavia, non è economico. È sistemico. Se gli Stati Uniti costringessero un alleato NATO a cedere territorio, anche solo attraverso pressioni economiche o implicite minacce, si configurerebbe una rottura dell’ordine di sicurezza nato nel dopoguerra.
Il cosiddetto “ordine internazionale basato sulle regole” non è un’astrazione ma è un contratto scritto nel 1945, con una clausola fondamentale – i confini non si cambiano con la forza e la sovranità degli alleati è inviolabile. Mettere in discussione la Groenlandia significa stracciare quel contratto.
Il presidente francese Emmanuel Macron è stato tra i pochi a esplicitare la posta in gioco, avvertendo che “la legge del più forte non può governare il mondo”. Anche il Regno Unito, tradizionale ponte tra Europa e Stati Uniti, avrebbe tracciato una linea rossa, invitando Washington a tenere “le mani lontane dalla Groenlandia”.
La prima vittima sarebbe la credibilità morale dell’Occidente. Dopo anni passati a condannare l’espansionismo russo in Ucraina e le mire cinesi nel Mar Cinese Meridionale, un’annessione americana svuoterebbe quegli argomenti di ogni forza.
METALLIRARI.COM © ALL RIGHTS RESERVED